
È forse l’ozio il padre di tutte le virtù?
Dall'uomo primitivo a Machiavelli, passando per Giordano Bruno: riflessione su quello che è comunemente ritenuto un vizio
Lo Spaccio de la bestia trionfante, dialogo filosofico in volgare scritto da Giordano Bruno nel 1584 contiene un'interessante discussione sul contrasto tra due istanze di valore, antitetiche per definizione, che periodicamente scopriamo scontrarsi nelle stagioni turbolente della cultura, della politica e della società di oggi.
Mi riferisco al conflitto tra l'ozio e l'operosità come presupposto della realizzazione dell'uomo. Si tratta di un contrasto che ha per fondamento il riconoscimento del valore del lavoro, della sua dignità e del suo significato nel contesto della vita associata. Questo riconoscimento, dal quale scaturiscono i presupposti della politica e le rivendicazioni della morale, richiede al contempo che sia precisata la connessione dell'ozio e dell'operosità con la felicità dell'uomo, con ciò che rende la sua vita piena di senso.
In altri termini, traducendo la questione in un'ottica di eudaimonismo, ossia di una dottrina che prescrive all'esistenza dell'uomo la ricerca della felicità, si impone alla filosofia un complesso di interrogazioni inderogabili: la felicità scaturisce dall'inattività, dall'occasione di godere dell'ozio? Oppure si presuppone che la felicità segua alla fatica e all'impegno, che sia il premio della solerzia? Ozio e operosità si escludono necessariamente, o possono in qualche modo interagire, influenzarsi reciprocamente, qualora sia in gioco la felicità? La soluzione offerta da Giordano Bruno a queste domande presenta un elaborazione originale, lontana dalle categorie ideologiche che ci sono più familiari e forse per questo particolarmente affascinante.
La filosofia di Bruno si fonda sull'adesione entusiastica alla cosmologia copernicana che, contestando la cosmologia aristotelico-tolemaica della tradizione, fondata sui presupposti della finitezza dell'universo e del geocentrismo, apre la strada alla dottrina dell'universo infinito, privo di centro e di periferia. Traendo spunto dalle premesse astronomiche, un'opera come lo Spaccio de la bestia trionfante caldeggia l'idea di una riforma etico-politica dell'uomo, vale a dire propone una riscrittura dei valori che organizzano il vincolo sociale. Servendosi dell'immagine mitologica del concilio degli dei, Bruno mette in scena un assemblea olimpica nella quale Giove, riprogrammando l'assegnazione delle costellazioni del cielo a specifiche divinità, avvia una riforma generale del firmamento, metafora dell'anima umana, per "spacciare" (espellere) i vizi e arruolare le virtù, arrestando così la decadenza morale che imperversa nel mondo divino.
Ciò che dell'opera mi interessa ripercorrere in questa sede è la sezione in cui Bruno discute il rapporto tra laboriosità e inoperosità, stabilendo quale posto sia loro assegnato nell'anima, ossia quale ruolo significativo debbano rivestire per le scelte esistenziali dell'uomo (Giordano Bruno, Spaccio de la bestia trionfante, III, 1, in idem, Dialoghi filosofici italiani, Mondadori, 2000, pagine 595-611). La scena dialogica si apre con l'intervento nell'assemblea olimpica delle divinità dell'Ozio e del Sonno, le quali, dopo l'assegnazione della costellazione di Perseo alla dea Sollecitudine, richiedono anch'essi una sede propria nel cielo. È l'Ozio a prendere la parola a nome di entrambi, intavolando un'aspra condanna delle dee Fatica e Sollecitudine, degli effetti nocivi che hanno arrecato all'umanità, a fronte di un accurato elogio dei propri meriti e talenti e di una sofisticata apologia delle proprie ragioni.
La dea Fatica avrebbe corrotto gli esseri umani, così esordisce l'inoperoso oratore, sottraendoli alla beatitudine leggendaria dell' "età dell'oro", lo stato di natura originario che circoscriveva un'esistenza serena e imperturbabile, caratterizzata dall'inoperosità, ormai irrimediabilmente dissolta. Scombussolando l'ordine naturale delle cose, la Fatica avrebbe suscitato nell'animo dell'uomo una serie di passioni che l'Ozio identifica come vizi pericolosissimi. La Fatica ha instillato la curiosità, l'ambizione, la superbia, nonché il desiderio dell'onore e della gloria. Succubi dell'incantesimo che la Fatica ha scagliato, gli uomini hanno abbandonato quell'uniformità dell'esistenza in cui godevano dell'inattività, della quiete e della solitudine, per essere sottoposti "a certa vertigine e precipizio", ossia per essere soggiogati al tempo della storia, il tempo delle vicissitudini e dell'incertezza, in cui l'azione dell'uomo, in passato regolata soltanto dalle più elementari necessità naturali, assume al presente una dimensione drammaticamente corale, che travalica l'orizzonte biologico, in quanto attività frenetica di uomini socialmente organizzati che danno vita al congegno della propria infelicità: la civiltà.
La Fatica, infatti, sostituisce al tempo biologico-individuale dell'inerzia, il tempo collettivo della società, delle istituzioni, dei saperi, delle arti, della vita affannosamente operosa. Questo passaggio a una nuova condizione determina l'estinzione della felicità primigenia, favorendo così, in nome di una sollecitazione all'impegno, allo sforzo, alla tensione, al conflitto, alla smania, l'imperio della disuguaglianza. Di conseguenza, quella Sollecitudine capace di "evertere le leggi de la natura" e "di far legge la sua libidine" ha generato nell'uomo l'egoismo, permettendo altresì che pullulassero quei vizi che accompagnano chi ossequia amorevolmente la Fatica: l'astuzia, la vanagloria, il disprezzo degli altri, la violenza, la malizia, la finzione, ai quali saranno da aggiungersi, come conseguenze nefaste, l'oppressione, il tormento, il terrore e la morte.
Il passaggio decisivo del ragionamento dell'Ozio è costituito dall'enucleazione delle ragioni politiche, fondamentali per disarmare le presunte virtù della Fatica, ragioni che emergono progressivamente attraverso l'intreccio di motivi psicologici, biologici e morali in cui si muove il biasimo dell'operosità. Bruno si confronta in questi passaggi con la tradizione letteraria dei classici (Esiodo, Ovidio, Virgilio, Seneca, ma anche con autori più recenti come Erasmo da Rotterdam e il suo Elogio della follia), per i quali il mito dell'età dell'oro riallaccia l'innocenza, l'uguaglianza e l'oziosità dei primi uomini alla genuinità, ossia all'assenza di vizi, ma soprattutto alla spontaneità che deriva dall'assenza di lavoro, di sforzo, di impegno: spontaneità della natura che offre a tutti il godimento dei suoi beni e provvede esaustivamente ai bisogni di ciascuno; spontaneità dell'uomo che, non avendo bisogno di nulla, vive una vita semplice e inserita organicamente nelle leggi della natura.
«Tutti magnificano l'età dell'oro – proclama l'Ozio – e poi stimano e predicano per virtù quella manigolda che la estinse, quella ch'ha trovato il mio ed il tuo». La Fatica «ha divisa e fatta propria a costui e colui non solo la terra (la quale è data a tutti gli animanti suoi), ma, ed oltre, il mare, e forse l'aria ancora». Come se ciò non bastasse questa dea perniciosa «ha messa la legge a gli altrui diletti, ed ha fatto che quel tanto che era bastante a tutti, vegna ad essere soverchio a questi e meno a quell'altri; onde questi, a suo mal grado, crapulano, quelli altri si muoiono di fame». Non contenta delle sue prodezze, essa «ha varcati gli mari, per violare quelle leggi della natura, confondendo que' popoli che la benigna madre distinse, e per propagare i vizii d'una generazione in un'altra» (Bruno, Dialoghi filosofici italiani, pp. 597-598).
Il nucleo politico del discorso rimarca gli effetti disastrosi della Fatica, alla quale l'Ozio imputa la dissoluzione dell'uguaglianza originaria attraverso l'introduzione del lavoro. In primo luogo il lavoro ha prodotto il senso della diversità o disparità che caratterizza le forze umane; in secondo luogo, il lavoro ha procreato un bisogno sconosciuto ai primi uomini: la proprietà privata, vale a dire la presunzione di disporre della terra, originariamente fruibile da tutti, in modo assoluto ed esclusivo; in terzo luogo il lavoro ha generato un perenne dissidio tra gli uomini, che si nutre di diffidenza, malevolenza e avidità, poiché germina dal desiderio di ricchezza.
Quest'ultimo bisogno, di caratura artefatta, ha promosso inevitabilmente l'invasione della disuguaglianza sociale, a causa della quale alcuni godono dell'abbondanza e del benessere, mentre altri soffrono di stenti, intrappolati nella penuria e nell'indigenza. Se nella stagione inoperosa ciascuno accedeva liberamente, e secondo le sue necessità, ai beni naturali, nella stagione laboriosa si assiste a una guerra di tutti contro tutti per l'accaparramento delle risorse, ossia a una distribuzione iniqua dei frutti della terra. È dall'esperienza di questa sostanziale ingiustizia, della disparità di condizioni, che trae origine, secondo l'Ozio, l'antagonismo universale, quella discordia e quell'avversione reciproca che, paradossalmente, sarebbero alla base della comunicazione tra gli uomini, ossia a fondamento dello scambio e del commercio, delle tecniche e delle scoperte scientifiche, dei viaggi e delle esplorazioni da un continente all'altro, degli incontri tra popoli e culture, insomma di tutto ciò che ha distrutto l'isolamento tipico dell'umanità primordiale nello stato di natura.
«Io forse sarò men faurito che costei? – lamenta l'Ozio – Io che col mio dolce che esce dalla bocca della voce de la natura ho insegnato di viver quieto, tranquillo e contento di questa vita presente e certa, e di prendere con grato affetto e mano il dolce che la natura porge». E il segno dei tempi, la decadenza dell'antica beatitudine in favore della scellerata operosità, è ovunque tangibile: «Non udite come a questi tempi, tardi accorgendosi il mondo di suoi mali, piange quel secolo, nel quale col mio governo mantenevo gaio e contento il geno umano, e con alte voci e lamenti abomina il secolo presente, in cui la Sollecitudine ed industriosa Fatica, conturbando, si dice moderar il tutto con il sprone dell'ambizioso Onore? » (Bruno, Dialoghi filosofici italiani, pagina 598).
Il tema dell'onore rappresenta in questi passaggi il culmine della critica dell'Ozio al sovvertimento di valori e al regresso morale prodotto dall'opera della Fatica. Il rispetto dell'onore assume, a parere dell'ozioso oratore, fosche ripercussioni socio-politiche che intaccano la stabilità e l'ordine dell'esistenza naturale, proclamando al mondo un'umanità perennemente insoddisfatta di sé, proiettata sul futuro a discapito del presente. In altri termini, la dea Fatica, non solo sembra disprezzare la costituzione naturale dell'uomo, costringendolo a subire passioni artificiose e corrosive della felicità originaria, bensì mira a generare scompiglio anche nel rapporto fra uomo e uomo, suscitando per mezzo dell'onore un feroce senso di competizione che costringe gli uni, fomentati dall'ambizione, a dettar legge sugli altri, schiacciati della rivalità. Ciò rappresenta il trionfo della legge umana sulla legge naturale, la sostituzione dell'ingiustizia civile alla giustizia naturale. L'apologia dell'Ozio si conclude, quindi, rivendicando per l'uomo quelle qualità, quei valori e quelle scelte che la Fatica ha sistematicamente destituito di validità.
Al termine della lunga orazione la parola passa a Giove, incaricato di decidere sul destino dell'Ozio e, soprattutto, di controbattere diligentemente al suo sofisticato discorso. La confutazione che Giove intraprende, passando in rassegna gli argomenti paradossali dell'Ozio, riassume in forma programmatica l'elogio della sollecitudine e il riconoscimento del valore delle opera umana che caratterizzano la riflessione teorica di Bruno, lasciando emergere, nelle parole di Giove, l'autentica filosofia del pensatore di Nola. L'intento è quello di smascherare il nucleo esiziale dell'apologia dell'inoperosità, contrapponendo alla presunta e ingannevole beatitudine originaria, l'immagine di un'umanità che dona un senso al tempo, vale a dire che lentamente e faticosamente si allontana dall'infelicità e dalla penuria dello stato di natura per raggiungere con le proprie forze il traguardo della civiltà.
La replica si impernia, inizialmente, sul riconoscimento del carattere disumano che contraddistingue la tanto nostalgicamente declamata età dell'oro. A parere di Giove la spontaneità, l'uguaglianza e l'uniformità che l'Ozio dignitosamente glorifica, costituiscono, a ben vedere, l'annullamento della storia, ossia la negazione dell'orizzonte di significato all'interno del quale l'uomo agisce in quanto essere razionale, capace di decidere tra il bene e il male, vale a dire capace di rivendicare per sé una dimensione morale. Se l'innocenza che l'Ozio attribuisce agli uomini primitivi sarà da intendersi legittimamente come inesperienza del vizio, allo stesso tempo essa dovrà interpretarsi come indifferenza o neutralità morale, una specie di intorpidimento o incoscienza quasi brutale che, sottraendo all'uomo responsabilità e dignità proprie, lo equipara a un qualsiasi altro animale al quale non sia ascrivibile alcun merito fuorché quello di essere un animale.
Al contrario, l'isolamento primordiale, nemico della diversità, non coincide affatto né con lo stato di perfezione, né con una condotta virtuosa, bensì con il prototipo di umanità ridotta a bestialità, che maschera con la carenza dei vizi la propria irresponsabilità. Una condotta propriamente umana richiede piuttosto l'impegno a varcare la soglia della propria fragilità, lo sforzo di aspirare alla virtù e di combattere il vizio. Ma sono la fatica, la difficoltà, la necessità, la durezza della vita a stimolare e acuire le facoltà umane, a rendere gli uomini solleciti e industriosi al fine di procurarsi i mezzi con cui fuoriuscire dai confini della bestialità ed emulare la felicità degli dei.
«Ne l'età dunque de l'oro – sostiene Giove - per l'Ocio gli uomini non erano piú virtuosi che sin al presente le bestie son virtuose, e forse erano piú stupidi che molte di queste. Or essendo tra essi per l'emulazione d'atti divini ed adattazione di spirituosi affetti nate le difficultadi, risorte le necessitadi, sono acuiti gl'ingegni, inventate le industrie, scoperte le arti». Infatti, a causa della privazione e del bisogno, «dalla profundità de l'intelletto umano si eccitano nove e maravigliose invenzioni». Di conseguenza, grazie alle «sollecite ed urgenti occupazioni», gli uomini si allontanano progressivamente «dall'esser bestiale» e «piú altamente s'approssimano a l'esser divino». (Bruno, Dialoghi filosofici italiani, pagina 602).
Nella contestazione del mito dell'età dell'oro emerge significativamente il modello antropologico al quale Bruno fa costantemente riferimento. Se gli uomini primitivi godevano dell'inoperosità, dell'isolamento e dell'autosufficienza, tale condizione apparteneva loro casualmente, non come essenza stessa della loro perfezione originaria, poiché in quella remota e indolente preistoria non sarebbero mai riusciti ad esprimere pienamente la propria natura di esseri umani. L'aureo paradiso descritto dall'Ozio, dunque, si presenta come un regno di "asinità", un paese di ignavia, ossia un luogo indeterminato e insignificante, in cui l'uomo trascorre un'esistenza vuota, inconsapevole della propria missione. Quegli uomini antichissimi, che mai avessero professato la religione dell'ozio, non sarebbero diventati affatto virtuosi, poiché sarebbe sempre mancata loro l'occasione di esercitare le loro doti naturali: il pensiero e l'azione attraverso l'impegno, la fatica, lo studio.
Ogni singola virtù si costituisce per Bruno sempre in relazione e in opposizione al vizio corrispondente, mai in assenza di esso. Coerentemente con questo presupposto, vizio e virtù scaturiscono dalla medesima radice e si realizzano solo a condizione che l'uno agisca sull'altro. Questa radice è l'opera dell'uomo: agire virtuosamente è possibile solo affrontando l'occasione di cadere nel vizio. Alla luce dell'interazione fra i contrari, nel gioco del rovesciamento dialogico che Bruno allestisce, gli effetti nocivi della civiltà, aspramente rilevati dall'Ozio, non sono altro che le opere, le creazioni e i traguardi più elevati della storia degli uomini, quegli sforzi con cui l'uomo cerca di eguagliare gli dei meritandosi la gloria nel consorzio civile. Questa gloria, altro volto dell'onore, attesta la natura sociale dell'uomo, il suo bisogno di eternarsi nella coscienza civile e di meritarsi perennemente il favore degli dei.
Inoltre, il riconoscimento del valore ultramondano della gloria, a discapito dell'inoperosità, instaura un nesso significativo tra religione e politica nel quadro dell'esaltazione dell'opera umana. Nell'individuazione degli effetti perniciosi che l'ozio produce per la comunità umana emerge vividamente l'influsso di Machiavelli sul pensiero di Bruno. Elogiare la gloria come apice dell'attività umana si traduce nel riconoscimento della religiose come fattore di coesione sociale e conservazione degli stati. Nelle parole di Giove risalta l'eco delle pagine machiavelliane sulla religione civile dei Romani nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. L'ozio assume qui una caratterizzazione religiosa fortemente negativa, dalla quale traspare il contraccolpo schiettamente politico. Anche Machiavelli contesta il mito dell'età dell'oro e riconosce nell'ozio il principale elemento di disgregazione del vivere associato (poiché gli uomini oziosi non operano per il bene della comunità), nonché la premessa al dissolversi dell'autorità dello stato, (poiché gli uomini oziosi non obbediscono alla legge).
Cionondimeno il cancelliere fiorentino sottolinea un elemento ideologicamente sostanziale, che motiverebbe, a discapito del Cristianesimo, la superiorità del Paganesimo. A differenza di una religiosità che, in nome dell'umiltà, della sopportazione e del disprezzo del mondo, svaluta le opere umane in favore della fede – ossia rende sostanzialmente gli uomini inattivi – Machiavelli caldeggia una devozione che concentrandosi tutta sulla gloria terrena e sulle imprese eroiche, riconosce nell'opera e nell'operosità il fulcro della dignità dell'uomo:
La religione antica (...) non beatificava se non uomini pieni di mondana gloria, come erano capitani di eserciti e principi di repubbliche. La nostra religione ha glorificato più gli uomini umili e contemplativi che gli attivi. Ha dipoi posto il sommo bene nella umiltà, abiezione, e nel dispregio delle cose umane; quell'altra lo poneva nella grandezza dello animo, nella fortezza del corpo ed in tutte le altre cose atte a fare gli uomini fortissimi. E se la religione nostra richiede che tu abbi in te fortezza, vuole che tu sia atto a patire piú che a fare una cosa forte.
Questo modo di vivere adunque pare che abbi renduto il mondo debole, e datolo in preda agli uomini scelerati, i quali sicuramente lo possono maneggiare, veggendo come l'università degli uomini per andare in Paradiso pensa piú a sopportare le sue battiture che a vendicarle. E benché paia che si sia effeminato il mondo e disarmato il Cielo, nasce piú senza dubbio dalla viltà degli uomini, che hanno interpretato la nostra religione secondo l'ozio e non secondo la virtù.
(Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, II, 27-35, pagina 299)





.jpg)

.jpg)
 Ricevi aggiornamenti e contenuti da Bisceglie
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Bisceglie 
.jpg)

.jpg)
(1).jpg)
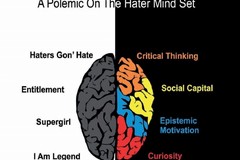




.jpg)





_articoj.jpg)

